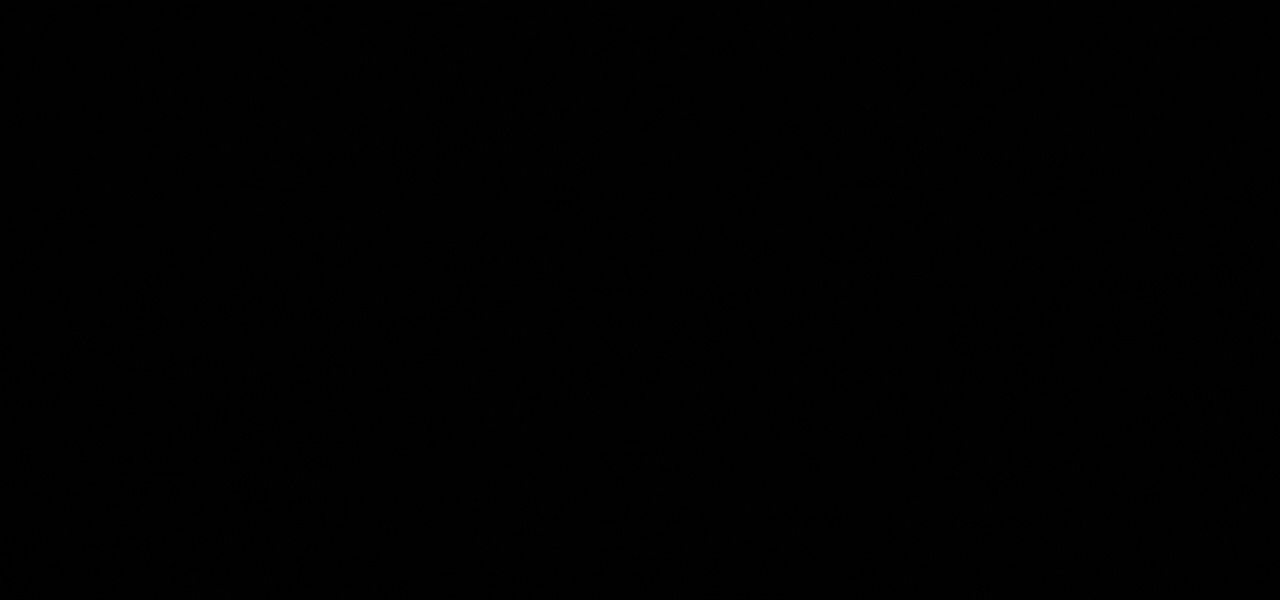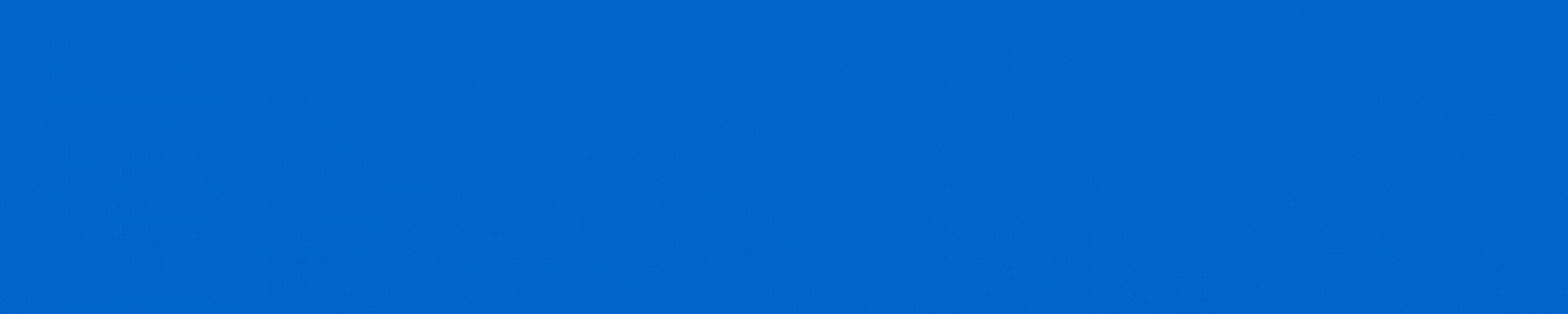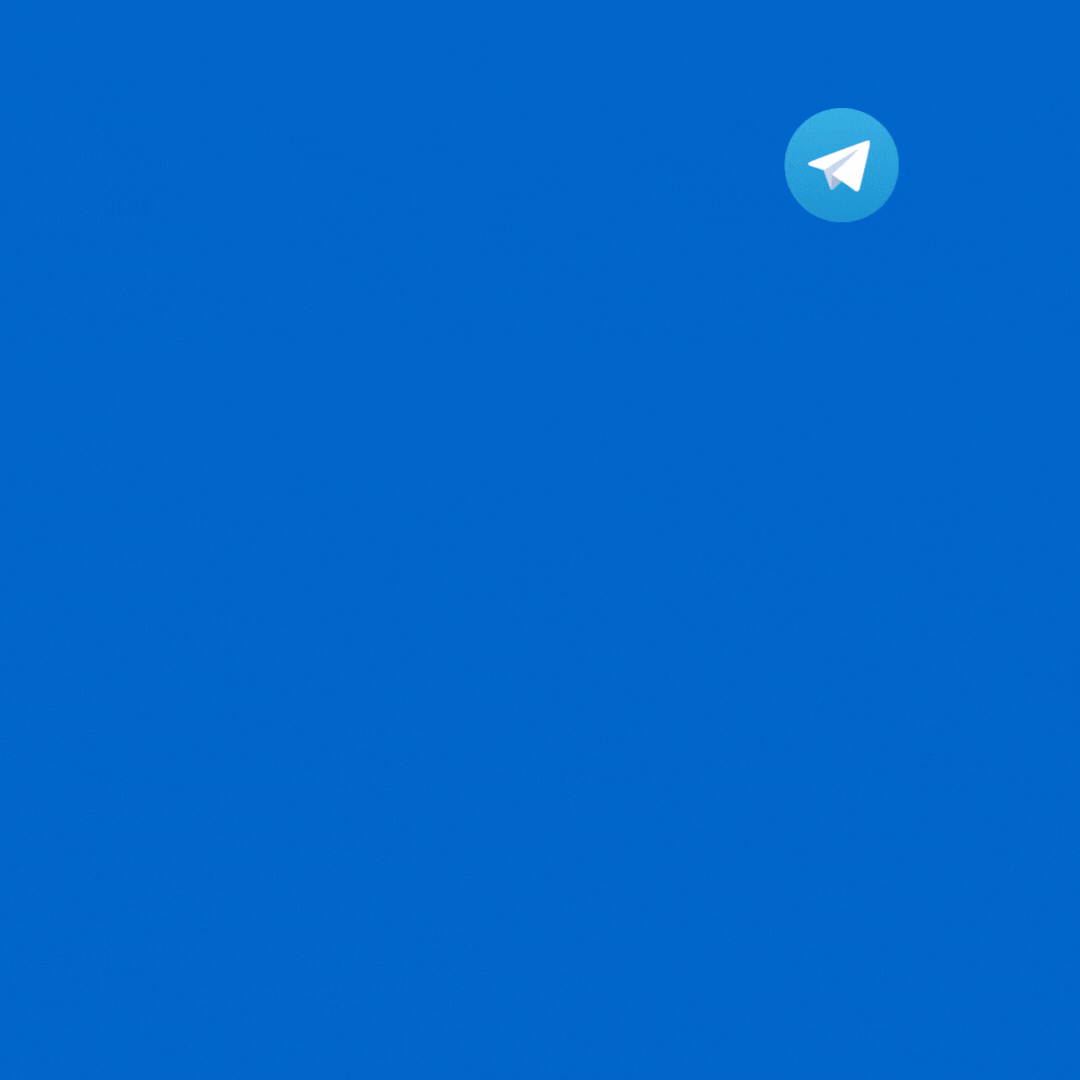L’intelligenza artificiale nell’educazione: la grande biforcazione
-
Redazione IDCERT
Il direttore del dipartimento Education and Skills dell’OCSE lancia un allarme che suona come una diagnosi clinica: l’intelligenza artificiale applicata all’educazione può costruire un campo di gioco equo o trasformarsi nell’ennesimo strumento di selezione sociale. Non esiste una terza via.
Andreas Schleicher, l’architetto del programma PISA che da vent’anni misura le competenze degli studenti quindicenni in tutto il mondo, ha scelto il primo summit internazionale sull’intelligenza artificiale a Napoli per articolare una riflessione che dovrebbe far riflettere chiunque si occupi di politiche educative: “L’IA potrà potenziare enormemente chi ha le risorse e le competenze giuste, lasciando indietro gli altri.”
La frase merita di essere scomposta. Perché Schleicher non sta parlando dell’ennesimo divario digitale da colmare con qualche donazione di tablet. Sta descrivendo un meccanismo più sottile e pericoloso: la creazione di un’aristocrazia cognitiva che saprà usare gli algoritmi per amplificare le proprie capacità, mentre chi resta escluso dalla formazione adeguata si troverà non solo più indietro, ma progressivamente irrilevante.
Il mito della neutralità tecnologica
L’intervista, pubblicata su Italia Oggi e curata da Alessandra Ricciardi, smonta un altro luogo comune: l’idea che l’intelligenza artificiale possa essere imparziale. “L’IA può contribuire a limitare i pregiudizi umani,” ha riconosciuto Schleicher, “ma può anche amplificarli e radicarli ancora di più.”
Gli algoritmi, in altre parole, non sono mai neutrali nel loro utilizzo. Se i dati su cui si addestrano sono parziali o distorti, anche i loro output lo saranno. La tecnologia riproduce e spesso amplifica le logiche di potere esistenti. Questo significa che senza una governance consapevole, l’intelligenza artificiale rischia di diventare uno strumento di cristallizzazione delle disuguaglianze piuttosto che di mobilità sociale.
Gli insegnanti come ingegneri del futuro
Ma c’è un passaggio dell’intervista che merita attenzione particolare. Alla domanda su chi determinerà l’evoluzione di questi processi, Schleicher ha risposto senza esitazione: “Le persone che determineranno come tutto questo si evolverà sono gli insegnanti nelle nostre classi. Sono gli ingegneri del nostro futuro.”
È una dichiarazione che restituisce centralità a una professione spesso trattata come destinataria passiva dell’innovazione tecnologica. Non sono le piattaforme, non sono gli algoritmi, non sono i colossi della Silicon Valley a determinare il futuro dell’educazione. Sono gli insegnanti, nella misura in cui sapranno comprendere, valutare e orientare l’uso di questi strumenti.
Ma questa responsabilità implica una condizione necessaria: che gli insegnanti possiedano le competenze per esercitarla. E qui torniamo al punto di partenza. Se le competenze digitali restano distribuite in modo diseguale, se mancano standard condivisi per valutarle e certificarle, se non esiste un sistema di formazione accessibile e riconosciuto, la biforcazione descritta da Schleicher diventa inevitabile.
La questione democratica
Dietro il dibattito tecnico sulle competenze digitali si nasconde una questione politica più profonda: chi avrà accesso agli strumenti per comprendere e governare il cambiamento tecnologico? Chi potrà permettersi la formazione necessaria? Chi resterà indietro?
Schleicher ha descritto l’intelligenza artificiale come uno strumento che può valorizzare le differenze tra studenti e offrire a ciascuno una possibilità di successo. Ma ha anche avvertito che questa possibilità non è automatica. Dipende da scelte precise: investimenti nella formazione, accesso universale agli strumenti, trasparenza nei criteri di valutazione, riconoscimento delle competenze indipendentemente dal contesto socioeconomico di partenza.
In un mondo dove l’intelligenza artificiale sta già ridisegnando il mercato del lavoro, la comunicazione, la produzione di conoscenza, garantire che tutti possiedano le competenze per interagire con questi sistemi non è più una questione di inclusione sociale. È una questione di sopravvivenza democratica.
Il tempo delle scelte
Il summit di Napoli, l’intervista di Schleicher, il lavoro sulla Prassi UNI: sono segnali di una consapevolezza che sta crescendo. Ma la consapevolezza da sola non basta. Servono decisioni concrete, investimenti strutturali, politiche pubbliche che mettano al centro non la tecnologia in sé, ma le persone che dovranno utilizzarla.
La biforcazione descritta da Schleicher è già qui. Non è uno scenario futuro. Sta accadendo ora, mentre alcuni imparano a governare gli algoritmi e altri restano spettatori passivi della propria marginalizzazione. La domanda non è se l’intelligenza artificiale cambierà l’educazione. La domanda è: cambierà per tutti o solo per chi ha le risorse per utilizzarla?
La risposta dipende dalle scelte che facciamo oggi. Dalla capacità di costruire standard condivisi, di investire nella formazione continua, di garantire che le competenze digitali siano un diritto e non un privilegio. Il futuro non è scritto negli algoritmi. È scritto nelle decisioni che prendiamo su chi avrà accesso a comprenderli.