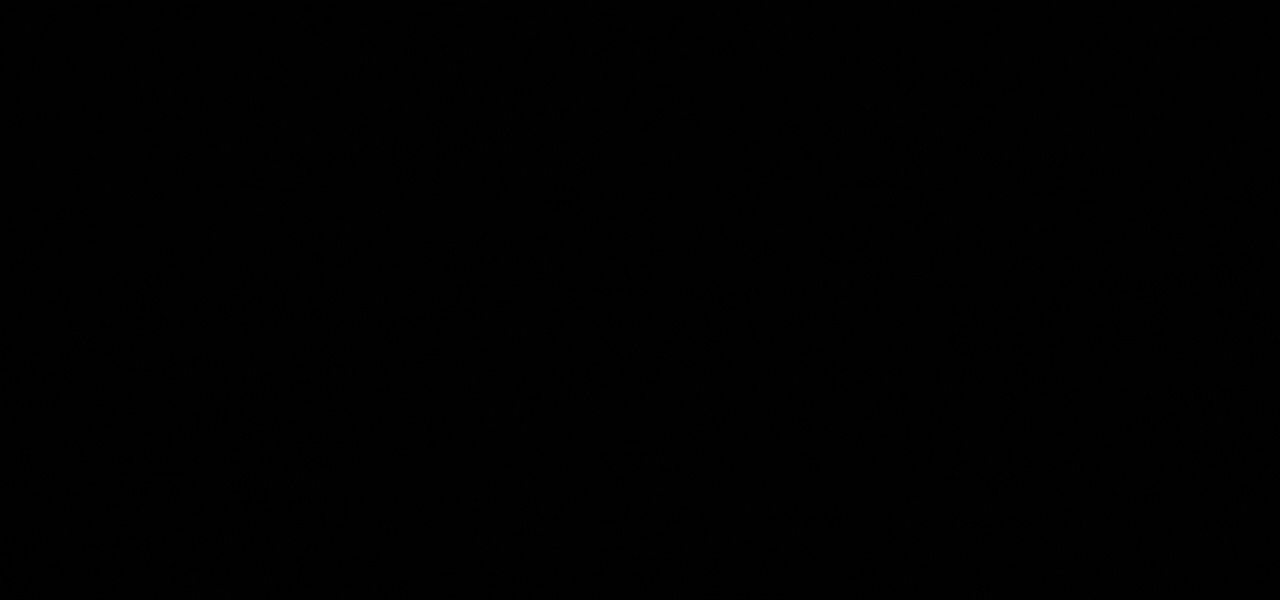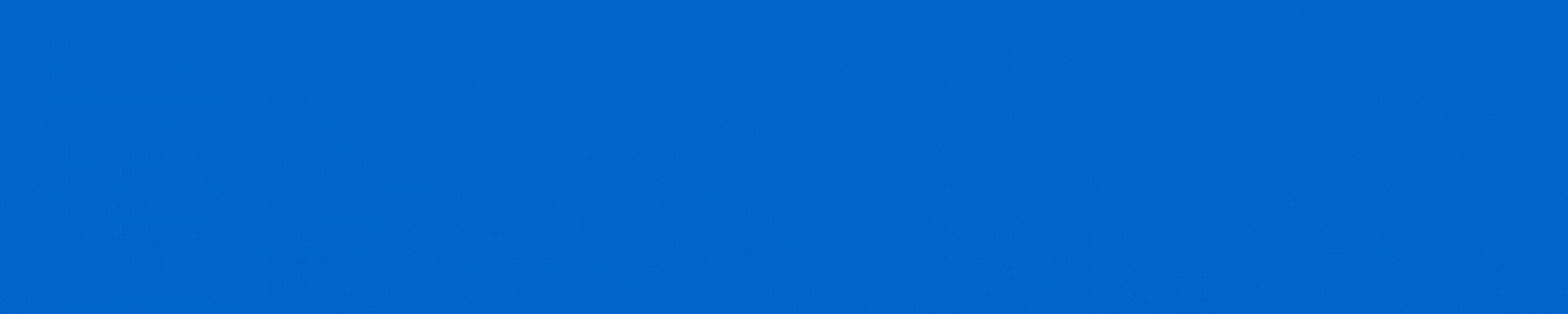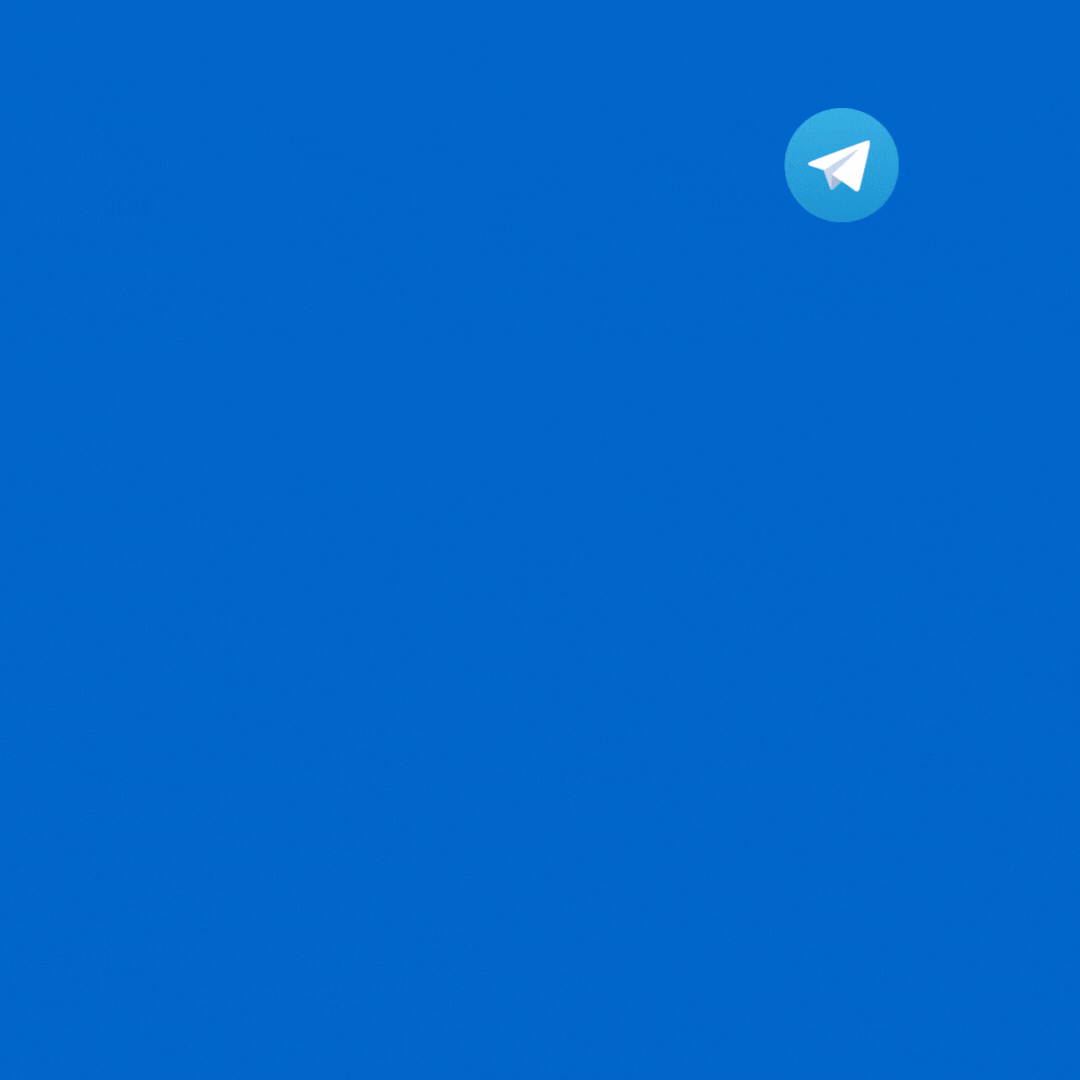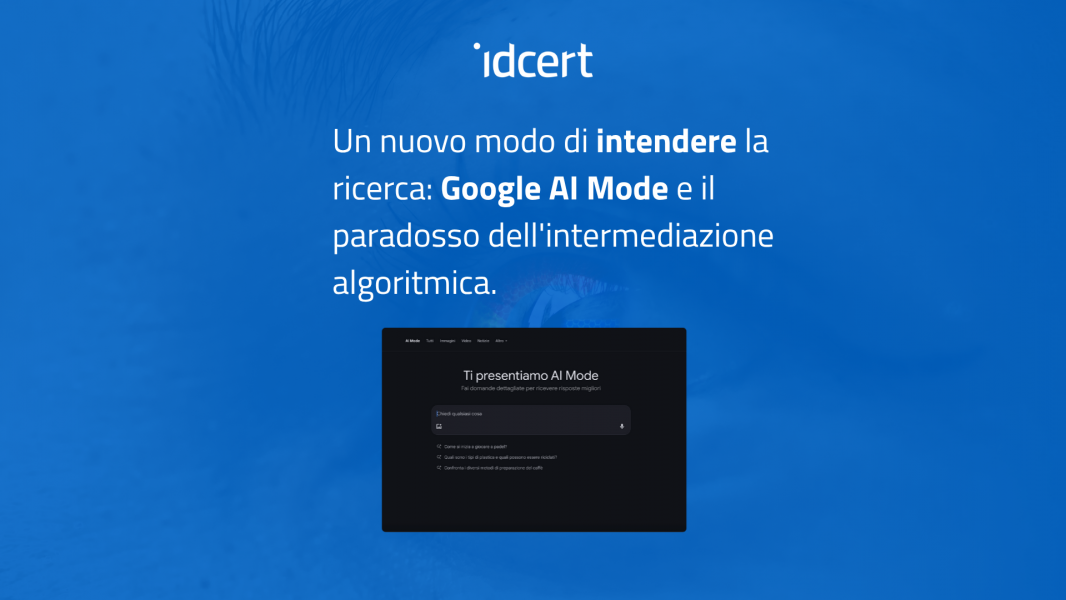
Un nuovo modo di intendere la ricerca: Google AI Mode
-
Redazione IDCERT
L’8 ottobre 2025 segna un punto di svolta nella storia di internet. Google ha esteso a oltre 200 paesi, Italia inclusa, la sua AI Mode: una modalità di ricerca che promette di rivoluzionare il rapporto tra utenti e informazione digitale. Ma dietro la retorica dell’innovazione si nasconde una questione cruciale per chiunque si occupi di competenze digitali, certificazioni e alfabetizzazione tecnologica: cosa significa cercare quando l’intelligenza artificiale si interpone tra noi e il web?
Quando la risposta sostituisce la ricerca: Oltre la SERP
Per più di vent’anni, il modello dominante della ricerca online si è fondato su un principio trasparente: Google indicizza il web e restituisce una lista di risultati. L’utente sceglie, clicca, valuta. È un processo che richiede competenze: capire quali fonti sono affidabili, confrontare informazioni, sviluppare senso critico.
AI Mode cambia radicalmente questo paradigma. Non più dieci link blu, ma una conversazione con un assistente intelligente alimentato da Gemini 2.5. Le domande possono essere lunghe, articolate, complesse. La risposta arriva sintetizzata, strutturata, accompagnata da fonti selezionate dall’algoritmo. Google definisce questo approccio query fan-out: il sistema scompone automaticamente la richiesta in sotto-domande, esplora simultaneamente centinaia di fonti e costruisce una risposta unica.
I numeri parlano chiaro: gli utenti che hanno adottato AI Mode formulano domande due o tre volte più lunghe rispetto alla ricerca tradizionale. La multimodalità consente di interrogare il sistema con testo, voce o immagini. L’esperienza diventa più naturale, immediata.
Efficiente.
Ma c’è un prezzo nascosto in questa efficienza.
L’intermediazione algoritmica e il collasso del traffico editoriale
La vera rivoluzione di AI Mode non sta nella tecnologia, ma nel cambiamento comportamentale che innesca. Quando la risposta è già sulla pagina di Google, perché cliccare su un link? Quando l’AI ha già sintetizzato, confrontato e organizzato le informazioni, quale incentivo ha l’utente a esplorare le fonti originali?
Google sostiene che i siti web non saranno penalizzati. Anzi, dalle prime analisi interne emergerebbe che i click provenienti da AI Overview sarebbero di “qualità superiore”, con utenti che trascorrono più tempo sulle pagine visitate. Un’affermazione che merita un’analisi più approfondita.
Il punto critico non è la qualità del singolo click, ma il loro volume. Se AI Mode risponde in modo sufficientemente esaustivo, la grande maggioranza degli utenti non avrà alcun motivo di approfondire. Solo una frazione ridotta, presumibilmente quella più motivata o specializzata, continuerà a visitare i siti originali. Per gli editori, per i creatori di contenuti, per chiunque produca informazione sul web, questo significa una cosa sola: erosione progressiva del traffico organico.
Non si tratta di speculazione. È la logica intrinseca del modello: maggiore è la qualità della sintesi dell’AI, minore è la necessità di consultare le fonti. L’intermediazione algoritmica si trasforma in sostituzione.
Il paradosso delle competenze digitali nell’era dell’AI generativa
Ed è qui che emerge il paradosso più rilevante per chi si occupa di competenze digitali. Mentre istituzioni come IDCERT e Fondazione Italia Digitale lavorano alla definizione di standard nazionali per valutare e certificare le competenze digitali – con la nuova Prassi di Riferimento UNI in fase di elaborazione proprio in questi mesi – il panorama tecnologico su cui si fondano queste competenze sta mutando radicalmente.
Quali competenze servono in un web mediato dall’intelligenza artificiale? Se la ricerca diventa conversazione, se l’AI seleziona, sintetizza e organizza automaticamente le informazioni, cosa resta della capacità di navigazione critica, di valutazione delle fonti, di analisi comparativa?
Il rischio non è l’obsolescenza delle competenze tradizionali, ma la loro invisibilità. L’utente medio potrebbe non percepire nemmeno la necessità di svilupparle. Se Google risponde, perché imparare a cercare? Se l’AI cita le fonti, perché verificarle? Se la sintesi è già pronta, perché leggere l’originale?
La questione non è accademica. Riguarda direttamente il cuore della trasformazione digitale che il Decreto Ministeriale 115/2024 intende supportare: come si forma una società digitalmente competente quando gli strumenti digitali stessi disincentivano l’esercizio di quelle competenze?
Verso una nuova alfabetizzazione: pensare con l’AI, non attraverso l’AI
La sfida per le istituzioni che si occupano di certificazione e formazione digitale è duplice. Da un lato, occorre riconoscere che le competenze non possono essere statiche. I framework europei come DigComp e DigCompEdu, devono evolvere per includere la capacità di interagire criticamente con sistemi di intelligenza artificiale generativa.
Dall’altro, serve un investimento culturale profondo. AI Mode e strumenti simili non sono semplicemente nuovi canali di ricerca. Sono architetture cognitive che modellano il nostro rapporto con l’informazione. Imparare a usarli criticamente significa comprendere cosa l’AI può vedere e cosa invece nasconde, quali bias incorpora, quali logiche economiche e tecniche ne guidano le scelte.
La vera competenza digitale nell’era dell’AI non sarà “saper usare AI Mode”, ma saper riconoscere quando fidarsi della sintesi algoritmica e quando invece è necessario tornare alle fonti, confrontare, dubitare, verificare. Significa sviluppare una forma di meta-cognizione: essere consapevoli non solo di cosa si sa, ma di come si arriva a saperlo.
La responsabilità dell’ecosistema: Google e la questione sistemica
Google non è un attore neutro. La sua scelta di integrare l’intelligenza artificiale generativa direttamente nella ricerca non risponde solo a esigenze di innovazione, ma a pressioni competitive. ChatGPT, Perplexity, Bing con Copilot: l’intero settore si sta muovendo verso modelli conversazionali. Google deve reagire o rischia di perdere il dominio su un mercato in cui detiene una quota superiore al 90% a livello globale.
Ma questa dinamica competitiva ha conseguenze sistemiche. Il web aperto, costruito in decenni di contributi distribuiti, rischia di diventare il combustibile invisibile di poche grandi piattaforme di AI. I creatori di contenuti forniscono i dati, l’AI li sintetizza, Google li distribuisce. Chi produce conoscenza perde visibilità e, con essa, la sostenibilità economica. Chi consuma conoscenza perde la capacità di valutarla criticamente.
Non si tratta di demonizzare la tecnologia, ma di riconoscere la necessità di governance. Serve trasparenza su come l’AI seleziona e pesa le fonti. Servono meccanismi di attribuzione che vadano oltre il semplice link citato in una sidebar. Serve soprattutto una discussione pubblica e informata sul futuro dell’ecosistema informativo digitale.
Imparare a cercare e non solo chiedere
AI Mode è arrivato. È potente, efficace, probabilmente inarrestabile. Ma il suo successo non deve tradursi nell’abbandono di competenze fondamentali. Cercare non è solo ottenere una risposta. È un processo di apprendimento, di verifica, di costruzione del senso critico.
Mentre Google trasforma la ricerca in conversazione, chi si occupa di competenze digitali ha il compito di trasformare gli utenti in interlocutori consapevoli. Non consumatori passivi di sintesi algoritmiche, ma cittadini digitali capaci di navigare con autonomia e giudizio un web sempre più mediato dall’intelligenza artificiale.
![]()